- La pace, in tutte le sue declinazioni, è il chiodo fisso dei politici (non mediorientali) che pensano al Medio Oriente. In Israele, quasi nessuno di coloro che incontriamo, pensa che la pace sia vicina.
Stando a questa differenza di argomenti, molti commentatori deducono che gli israeliani siano guerrafondai e dunque giungono alla conclusione che sia lo Stato ebraico a dover “avere il coraggio” di “fare un passo avanti” nei negoziati. Quante volte abbiamo sentito queste frasi stereotipate, da parte di Obama, delle agenzie dell’Onu, dei commissari europei, di tutti i nostri parlamentari, del Quartetto e delle altre orchestre diplomatiche! Vista da Israele, la pace appare come un qualcosa di molto più concreto: assenza di guerra. E per questo appare lontana.
Tra una minaccia e l’altra, la gente cerca in tutti i modi di vivere nel massimo della calma. Non ci sono sui muri i poster “Keep Calm and Carry On” come nella Gran Bretagna della Seconda Guerra Mondiale, ma è come se ci fossero, stampate nella mente di tutti. La Gerusalemme di oggi appare all’osservatore molto più rilassata e pacifica di quella di tre, quattro anni fa. Dove c’erano le armi, ora non ci sono più. Dove i soldati tornavano in licenza tenendosi il loro fucile (pronto all’uso), ora sono in borghese e disarmati, come avviene in tutti gli eserciti in tempo di pace. Dove gli studenti giravano sotto la scorta di volontari armati, ora camminano, chiacchierano e mangiano liberi e senza protettori. Dove c’erano guardie giurate e metal detector, davanti a negozi, vie strette e affollate, centri commerciali, ora (a parte qualche eccezione) si può entrare e uscire senza essere perquisiti o interrogati. Le vie pedonali del centro sono affollate di giovani e giovanissimi che si divertono nei locali, con la musica alta, all’ultima moda. Complessini improvvisati suonano per le strade. Due violinisti che sembrano usciti da un quadro di Chagall intrattengono i passanti di fronte a luminose sfere animate, un’installazione di arte contemporanea piazzata all’ingresso del corso Mamilla, proprio dove, qualche anno fa, era pieno di polizia.
Gaia apocalisse? Calma apparente? Qui nessuno crede che la quiete duri in eterno. Ci sono abituati. Ma ogni giorno di pace conquistato è un dono, non tanto del cielo, quanto dell’organizzazione della difesa. Il “muro” così tanto stigmatizzato in Occidente, qui in questa landa d’Oriente è visto come l’unico strumento in grado di fare la differenza. Dopo la sua costruzione, la barriera difensiva ha abbattuto il numero di attentati suicidi. Non c’è solo quello. La cooperazione della polizia dell’Autorità Palestinese (Anp) pare stia funzionando a dovere. Almeno per ora, visto che gli interessi sulla sicurezza, a spese di Hamas, stanno convergendo. Un ufficiale dell’Amministrazione Civile di Hebron ci mostra un video su YouTube che pare impossibile a un medio osservatore occidentale: la polizia palestinese, in tenuta anti-sommossa, carica i manifestanti di Hamas. La guerra interna alla Palestina sta garantendo questa prolungata pace in Israele.
Sulle soluzioni di lungo periodo, pochi osano esprimersi. Quando si parlava troppo di pace negli anni ’90, è poi arrivata la Seconda Intifada del 2000. Con tre-quattro attentati al giorno, la popolazione di Israele aveva vacillato sotto i colpi. Per la prima volta dal 1948 aveva creduto seriamente alla possibilità di estinzione fisica.
Questo non vuol dire che non vi siano delle azioni concrete verso la pace. Ci sono eccome. Ma al livello di base, quello dei rapporti fra comunità, nelle azioni individuali, nelle relazioni fra persone. E non vengono riconosciute in Occidente, perché sono fraintese, più o meno volutamente, come atti di “occupazione”. Parliamo con un imprenditore, nei Territori: dei suoi 80 operai, 42 sono palestinesi. Hanno lo stesso salario e gli stessi diritti dei suoi impiegati israeliani. Viaggiano assieme durante le ferie. Il suo fondatore ci spiega di non aver alcun incentivo fiscale: ha trasferito lì (da Tel Aviv) la sua fabbrica, per favorire l’occupazione (in senso lavorativo) nei Territori. Ebbene, quella stessa fabbrica, che produce prodotti in plastica per i bagni, è vittima del boicottaggio internazionale, perché strumento di “occupazione” (in senso militare) dei Territori.
Assistiamo ai colloqui all’ufficio assistenza nell’Amministrazione Civile di Hebron, la branca amministrativa delle forze armate israeliane locali. I palestinesi fanno regolarmente la coda per venire a chiedere informazioni a soldati e soldatesse, su servizi sociali e benefit di cui hanno diritto. Un funzionario civile, che vuole mantenere l’anonimato, ci confida che molte ragazze discriminate e maltrattate, bambine costrette a sposarsi prematuramente e gay che rischiano la persecuzione in Palestina, vengono salvati “ogni settimana”. Sono loro che si rivolgono all’esercito per chiedere protezione. Tutto questo, dal punto di vista dei pacifisti occidentali è solo “occupazione”: Hebron viene tuttora considerata come uno scempio israeliano.
A Ma’ale Adumim, sobborgo di Gerusalemme oggetto di un’infinita contesa diplomatica, molti impiegati comunali sono musulmani, gli addetti alla sicurezza sono drusi, i beduini attendono pazientemente di essere assunti nei cantieri come muratori. Non lavorano e non guadagnano perché la comunità internazionale, temendo la “minaccia” dei nuovi insediamenti di “coloni”, ha ordinato l’alt di tutti i lavori edili.
Nell’università di Ariel, un terzo degli studenti e delle studentesse sono palestinesi. Studiano assieme agli israeliani, aspirano ad inserirsi nel mondo del lavoro esattamente come i loro coetanei dello Stato ebraico. Ariel, splendido giardino nel deserto, con i suoi campus e i dormitori grandi quanto un’intera cittadina, è un’istituzione maledetta dalla comunità internazionale. Barack Obama, nella sua visita in Israele, non ha nemmeno voluto vedere i suoi studenti fra coloro che hanno assistito al suo discorso rivolto ai giovani. È in un “territorio occupato”, quindi è boicottata dal mondo e rifiutata dai Grandi.
A Sud di Tel Aviv, una Ong, “Save a Child’s Heart” opera al cuore i bambini palestinesi che arrivano sia dalla Cisgiordania che da Gaza. Sì, anche da Gaza, come ci spiega il cardiologo Sion Houri: arrivano regolarmente dalla città controllata da Hamas e contatti con i medici palestinesi avvengono costantemente. Unico problema: i ritardi. L’esercito pare abbia trovato esplosivi in più di un’ambulanza e allora deve controllarle tutte. Già è capitato che i terroristi approfittassero dell’assistenza medica israeliana per farsi saltare negli ospedali.
Eppure per l’opinione pubblica occidentale, gli ospedali israeliani che curano i bambini palestinesi sono solo una “foglia di fico”, per nascondere uno “Stato dell’Apartheid”. Mentre i terroristi sono “una reazione all’occupazione”. È Apartheid uno Stato in cui la popolazione palestinese delle aree B (ad amministrazione mista israelo-palestinese) paga le tasse all’Anp, ma usufruisce di sanità, strade, luce e gas forniti da Israele, come ci spiega un mukhtar (capo villaggio) palestinese? È Apartheid uno Stato in cui gli israeliani non possono entrare, non solo nei luoghi santi musulmani, ma nemmeno nelle aree A (ad amministrazione palestinese)? Lo è, secondo opinioni pubbliche lontane e autoreferenziali, che dicono di amare la “pace”, ma rifiutano di vedere le concrete azioni di pace che quaggiù vengono compiute quotidianamente.















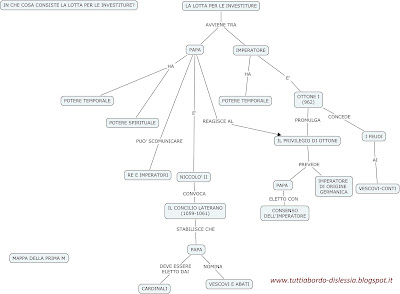

.jpg)
